IL GIORNO BUONO PER MORIRE – CRONACA DEL VIAGGIO DI PIETRO D’AMICO VERSO IL SUICIDIO
Entra in uno dei tanti bar di fronte alla Stazione Centrale, a Milano. Il suo treno parte fra mezz’ora, ha tempo per un espresso. Lo ordina lungo e non lo zucchera. Lo beve in tre sorsi, lascia una moneta di fianco al piattino, saluta ed esce. Prima di seguirlo faccio in tempo a notare il colore e la forma della schiuma che si è rappresa sulle pareti interne della tazzina, ed è un’immagine che non scorderò più, perché l’uomo che ha appena bevuto da quella tazzina cesserà di vivere fra esattamente ventidue ore.
Io lo so, lo sa anche lui, ed è per questo che, passando davanti al bar, mi ha detto: «Sergio, andiamo a prendere un ultimo caffè come si deve, ché in Svizzera li fanno ‘na chiavica».

Quarantotto ore prima, ha telefonato da un paesino del Sud e preso il suo appuntamento con la morte a Basilea, per le otto e trenta del mattino di un giorno di primavera. La sentenza, mi dice, in realtà gli è stata comunicata da tempo, con la diagnosi di una malattia neurodegenerativa devastante, che nel giro di qualche anno lo ridurrà a un vegetale e infine lo ucciderà.
Nel 2010 è andato la prima volta in Svizzera per avviare la pratica di suicidio, illegale in Italia, e ha scoperto che anche lì darsi la morte non è semplice: serve il nulla osta di due medici diversi, che la deontologia obbliga a cercare di dissuaderti. Nei due anni successivi, è stato respinto tre volte.
Intanto la malattia ha continuato il suo corso, e da tempo lui teme di superare quello che gli assistenti al suicidio definiscono il «punto di non ritorno», oltre il quale il tuo degrado psicofisico non ti consente più di aprire la valvola della flebo con la sostanza letale (la legge vieta che sia il medico a farlo al tuo posto, si tratterebbe di eutanasia). È il paradosso del suicidio assistito: devi avere ancora vita a sufficienza perché ti sia concesso di togliertela.
Ma è un uomo tenace, uno che si è fatto strada dal nulla, ha preso due lauree e al culmine della carriera è arrivato a disporre dei destini di centinaia di suoi simili: all’inizio di quest’anno è tornato alla carica, si è sottoposto a nuove visite, si è fatto preparare l’ennesima perizia, l’ha spedita in Svizzera, ha ricevuto un sms. Me lo mostra sul display del suo cellulare. Mittente: Erika Preisig, +41.79 eccetera. Il testo è in italiano: «Puo venire morire giovedi proximo».

Preisig è un medico e un’assistente al suicidio. Tre giorni la settimana è impegnata in ambulatorio a Basilea, quindi a chi vuole morire dà appuntamento il lunedì o il giovedì, i suoi giorni liberi. Lui la conosce bene: da tre anni le scrive lettere che esordiscono tutte con la stessa frase: «Dolce sorella mia».
Quando ha riattaccato, dopo averla chiamata per accordarsi sul luogo e sull’ora in cui lascerà questo mondo, erano da poco passate le undici di mattino di un venerdì: sapeva di avere, al netto degli imprevisti, centoquarantuno ore e trenta minuti di vita.
Quando lo vedo, il lunedì mattina, gliene sono rimaste poco più di sessantotto: arriva in macchina nella via dove mi ha chiesto di aspettarlo, lontano dal centro per non rischiare di incontrare i conoscenti, la moglie, i figli a cui ha raccontato che sarà a Napoli per l’ennesimo consulto con uno specialista. «Se sapessero cosa sto andando a fare mi incatenerebbero a casa», dice con un sorriso amaro.

Litighiamo subito, perché vorrebbe che guidassi la macchina fino a Napoli, ma io mi oppongo, non voglio avere una parte attiva nel suo viaggio verso Basilea. «Solo fino a Napoli e poi prendiamo il Frecciarossa, che ti costa?», insiste. Rispondo che può costarmi ¬l’anima, oltre a qualche anno di galera. «Sergio, quanto sei stronzo, nemmeno a un uomo che sta per morire puoi fare un favore», dice, ma ci aggiunge una carezza sulla guancia. «Ma sì, hai ragione, lo stronzo sono io: monta e jammucinne, va’».
Guida con una lentezza esasperante, doversi concentrare sulla strada lo stanca parecchio. Sono duecento chilometri fino a Napoli, milletrecento fino a Basilea, sessantasette ore e tre quarti di vita.
Mi ha voluto accanto a sé perché rimanesse una testimonianza della sua scelta, delle ragioni che l’hanno spinto a compierla, di come sia costretto – trascrivo le sue parole – a «umiliarsi un uomo, viaggiando lontano da casa come una specie di clandestino, per poter esercitare fino alle estreme conseguenze il proprio sacrosanto diritto al libero arbitrio, che nel nostro Paese ci viene negato». E sono qui, un perfetto estraneo nell’abitacolo della macchina dove dovrebbero essere i suoi familiari, a chiedermi se sia stato lui ad abbandonarli o se invece, come sostiene, non sia il contrario.

«I familiari non capiscono le tue sofferenze», dice in tono rabbioso, «non capiscono che quando sei condannato la vita può diventare un peso insopportabile, che ogni volta che vedi sorgere il sole e sai che ti aspetta un altro giorno da vivere è come se ti caricassero sulle spalle un altro macigno e ti spingessero a camminare a frustate. No, non lo capiscono, o forse non vogliono. Tutto quello che vogliono è che tu continui a esistere, per la loro consolazione, per il loro puro egoismo, per rimandare il più possibile il momento in cui dovranno avere a che fare con la tua morte. Però poi cercano di evitarti, trovano ogni scusa per lasciarti da solo, perché la tua malattia li mette a disagio».
Nei suoi occhi c’è un’amarezza infinita, e un risentimento che in parte è rivolto a me, perché crede che anch’io sia di quelli che non capiscono. Lo crede da quando ci siamo fermati in un bar lungo la strada per comprare dei panini che abbiamo mangiato in macchina, mentre continuava a guidare. Erano panini appetitosi, di pane casereccio e prosciutto e formaggio locale. Mangiava con gusto, e ho osservato che non sembrava uno pronto a morire, e la cosa l’ha mandato su tutte le furie. «E secondo te che cazzo dovrei fare, digiunare, così crepo con la fame?», ha urlato.

«Pensi che mi faccia piacere andarmene, eh? Pensi che non preferirei continuare a godermi la vita? Il fatto è che quando sei nelle mie condizioni un momento per andartene lo devi scegliere, e deve essere prima di rincoglionirti del tutto, prima di non essere più capace di aprire quella cazzo di valvola, capito? Prima, quando ancora hai appetito e voglia di berti un vino fresco e farti una scopata, perché dopo è troppo tardi. Quindi non rompermi mai più i coglioni con questa storia».
Così è calato il silenzio, che mi è parso durare un’eternità ed era intollerabile perché ormai le ore erano sessantaquattro scarse, fino a quando non mi ha appoggiato una mano sulla spalla e, come se fra noi non fosse successo nulla, ha detto: «Sergio, che hai, perché non parli più?». Con il Vesuvio all’orizzonte, ha avuto la tremenda prontezza di citare l’adagio vedi Napoli e poi muori, e ha aggiunto: «Non posso biasimarli, sai».

«Chi non puoi biasimare?», ho chiesto. «I miei. Quelli come loro. Tutti quelli che mi vorrebbero vivo. Non possiamo sopportare la vista di una persona se sappiamo con precisione l’ora in cui morirà. Riusciamo ad affrontare la morte solo quando ci coglie alla sprovvista. È uno dei pochi casi in cui la certezza spaventa più dell’ignoto. Tu, per esempio, la sopporti la mia presenza?». Rispondo di sì. Entrambi sappiamo che sto mentendo.
Sul frecciarossa per Roma, e su quello che il giorno dopo ci porta a Milano, parla in continuazione, come se avesse orrore del silenzio, come se una vita senza conversazione fosse una vita sprecata. Discute in modo brillante di tutto, di filosofia, di musica, di storia e di fisica delle particelle subatomiche. L’unico argomento che liquida in due frasi lapidarie è la fede: «Una gran fregatura», dice, lui che è cresciuto in una famiglia rigidamente cattolica.

«Non posso più accettare l’idea di un Dio che permetta tanta sofferenza».
A Roma, dove abbiamo fatto una sosta perché non se la sentiva di proseguire, ha voluto entrare in Santa Maria Maggiore. Si è messo a sedere sul plinto di una colonna ed è stato per un po’ con lo sguardo fisso verso l’abside. Ho pensato che stesse pregando, ma quando mi sono avvicinato ha detto: «Andiamocene a mangiare qualcosa, che è meglio».
Tace solo quando l’emicrania prende il sopravvento, e allora chiede a me di parlare. «Raccontami delle storie», dice. «Di che genere?», rispondo.
«Del genere che non annoia: ‘sto viaggio è lungo assai», e mi sorprendo a rivelargli cose inconfessabili che non ho mai raccontato a nessuno. Alcune lo fanno ridere, e penso che un uomo non ride mentre va incontro alla propria morte. O forse è solo una convenzione a cui siamo stati educati. A tratti mi perdo nei pensieri, in silenzio fisso la campagna che scorre troppo veloce oltre il finestrino, faccio il calcolo delle ore che restano. Allora lui mi scuote una spalla e mi dice: «Fatti coraggio, non è niente».

È ossessionato dalla possibilità che la famiglia intuisca le sue intenzioni e metta la polizia sulle sue tracce. Ha tolto la batteria dal cellulare, nelle stazioni si guarda in giro alla ricerca delle telecamere, paga tutto in contanti.
In albergo a Milano, mentre estrae dalla borsa a tracolla sei banconote da cinquanta nuove di zecca per pagare la camera, l’uomo alla reception guarda con sospetto e fastidio i suoi capelli sporchi, l’impermeabile sgualcito, il volto deformato dalla stanchezza del viaggio, la camminata sofferente sostenuta dalla stampella – tutte cose che stonano con l’arredamento di design – e l’unico bagaglio, troppo piccolo anche per una sola notte.
È la stessa cosa che mi chiedo anch’io dall’altro ieri: che cosa mette in valigia un uomo che va a morire? Che cosa c’è nelle sue tasche, e perché mi incuriosisce più di quello che c’è nella sua testa?
Lo scopro quando lo accompagno in camera e lui svuota il contenuto della borsa per disporre tutto con ordine maniacale sulla scrivania. C’è poco più di niente. Due grosse buste indirizzate ai familiari. Una cartelletta azzurra gonfia di perizie mediche. Un portafoglio con i contanti. Le chiavi della macchina che spedirà alla famiglia con lo scontrino di un parcheggio di Napoli. Un sacchetto di plastica con un’arancia e una confezione di biscotti.

Niente biancheria, niente vestiti di ricambio, nessun accessorio da bagno: per contenerli ci vorrebbe almeno una borsa quarantotto ore, e a lui non ne restano che trentacinque.
Sul treno per Zurigo, dopo l’ultimo caffè davanti alla Centrale, non parla più. Da quando abbiamo passato il confine e le guardie di frontiera svizzere e i finanzieri italiani sono scesi, fissa il cielo oltre le vette, come se stesse studiando la rotta. «Leggi un po’», mi dice, «fa’ qualcosa per distrarti, lasciami guardare queste belle montagne».
Penso, sul momento, che sia il suo modo di prepararsi ad abbandonare la terra, di recidere uno a uno i fili che lo legano al mondo, a cominciare dalla conversazione e dal rapporto con gli altri esseri viventi. Scoprirò, poi, che non è così: lui è semplicemente angosciato dalla prospettiva di non riuscire a superare l’ultimo ostacolo che lo separa dalla morte, il consulto con il medico di Zurigo che dovrà firmare il secondo nulla osta, il giorno precedente il suicidio.
Arriviamo all’ambulatorio verso le cinque del pomeriggio, in ritardo di mezz’ora. Teme di non trovare più il dottore, che invece è lì ad aspettarlo e lo accoglie con una stretta di mano, parlando in un italiano dal forte accento tedesco. Il colloquio dura tre quarti d’ora. Il medico è un uomo tarchiato con una folta barba candida, indossa una camicia da montagna che – penso in modo del tutto incongruente – mi ricorda il nonno di Heidi, fa domande a raffica.

Quando finalmente dice: «Per me tutto a posto, può morire tomani», lui – un uomo che per tutta la vita ha guidato le sorti di altri uomini – cade in ginocchio, gli afferra la mano, la bacia, dice: «Grazie, dottore, che Dio la benedica».
Ora è sollevato, quasi allegro. Ha ripreso a parlare e alla stazione di Zurigo, mentre aspettiamo il treno per Basilea, vuole comprare un sandwich con würstel di vitello. Lo mangiamo in piedi sulla banchina: sarà la sua ultima cena.
Alla reception dell’albergo di Basilea il personale è più cortese che a Milano. Quando ha prenotato, lui ha pagato anche per la notte precedente, e la donna in tailleur nero gli dice che potrà farsi rimborsare i soldi dalla sua agenzia di viaggio. Le risponde con un mezzo sorriso: «Signorina, non ha importanza».
La dottoressa Preisig lo raggiunge nella sua stanza un’ora dopo. Si abbracciano con un’intensità struggente. Preisig gli fa firmare gli incartamenti, all’improvviso lui è agitato, insofferente: «Erika, non possiamo farlo stasera?». Lei, paziente, spiega che è impossibile: la morte ha bisogno dell’apparato burocratico, che la notte non lavora. «E se stanotte dovesse succederti qualcosa? Se domattina tu non potessi venire?».

Fanno quasi tutti così, mi spiegherà poi la dottoressa: giunti a questo punto non hanno paura della morte, ma di non poter morire. Le chiede di accompagnarlo a fare una passeggiata: «Voglio vedere il centro storico, non ci sono mai stato».
Camminano sottobraccio, lentamente, nei vicoli deserti. Fa freddo, e lui non ha altri vestiti che quelli con cui è uscito di casa tre giorni prima, vestiti da primavera del Sud, adatti a un luogo soleggiato, immensamente lontano. Dopo un po’ è stanco, vuole tornare in albergo. Quando Preisig sale in macchina, le dice: «Stai attenta, guida piano». L’ultima cosa che fa prima di ritirarsi in camera è chiedere alla ragazza in tailleur di prenotargli un taxi per il mattino: «Mi raccomando, alle otto e venti precise: ho un appuntamento importante».

Il monolocale al piano terra dove Preisig accompagna al suicidio è in un quartiere residenziale poco lontano dal centro. Un secolo fa ospitava una sinagoga. Lei lo ha fatto ristrutturare cercando di renderlo il più accogliente possibile, ma il risultato è che sembra la stanza di un residence per ex mariti cacciati di casa: c’è un letto singolo, una poltrona, un angolo cottura a vista, un assortimento di cd, un tavolino da salotto con un vassoio di cioccolatini, nessuna finestra, la gelida presenza dello stelo di alluminio per appendere la flebo.
Arriviamo qualche minuto prima delle otto e trenta. Entra, saluta, dà un’occhiata rapida alla stanza, guarda l’orologio, chiede se è tutto a posto con un tono distaccato, quasi militare. Anche Erika cerca di sembrare fredda e padrona di sé («È quello che le persone si aspettano, a questo punto»), ma è evidente che le costa fatica. Lui estrae dalla borsa le lettere per i familiari, chiede che vengano spedite dopo la sua morte insieme all’urna con le ceneri, si sfila le scarpe, si siede sulla poltrona. «Erika, angelo mio», dice, stavolta con dolcezza, «vieni, non perdiamo tempo».

Alle otto e quarantacinque, Preisig gli infila l’ago nella vena, e mette in comunicazione il suo corpo con la sacca di soluzione fisiologica nella quale ha già disciolto una dose letale di Pentobarbital di sodio. Da adesso, la sola cosa che lo separa dalla morte è un pezzetto di plastica arancione del valore di pochi centesimi, la valvola che dovrà aprire. Erika gliela porge, lui la prende delicatamente, come se fosse una farfalla viva. Nei suoi occhi c’è una gratitudine incalcolabile.
«Funzionerà, vero? Non soffrirò?», dice. «No, non soffrirai. Dormirai un sonno profondo». «Grazie, angelo mio, che Dio te ne renda merito». Poi ha un ripensamento. «Sergio», dice, «portami la borsa». Gliela metto in grembo, rovista tra le carte e l’arancia ancora intatta e ne estrae un piccolo crocifisso. Lo stringe nell’altra mano, mi guarda e scrolla le spalle come per dirmi: che ci vuoi fare?
Poi tutto accade velocemente. Ruedi, il fratello di Erika, accende la telecamera: il video servirà a dimostrare che in questa stanza un uomo si è tolto la vita di sua volontà. La polizia lo dovrà visionare, ma verrà chiamata solo a decesso avvenuto: per paradosso, se fosse presente dovrebbe impedire il suicidio.
Erika rivolge le tre domande di rito: nome, data di nascita, sei cosciente di quello che accadrà quando aprirai la valvola. Alla terza, la risposta è: «Finalmente sarò libero». Tocca a lui aprire la valvola, alle nove e sei minuti. Nello stesso momento comincia a recitare l’Ave Maria. Erika, in ginocchio, gli accarezza la mano e sussurra il suo nome come un mantra. Quando si arriva a «prega per noi peccatori», la voce è un nastro al rallentatore. Non pronuncerà mai l’amen finale. Il suo cuore si ferma alle nove e dieci.
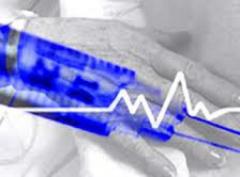
Mentre aspettiamo la polizia, che arriverà tra poco insieme al procuratore capo e al medico legale, guardo il corpo di quest’uomo che ho conosciuto in modo così superficiale eppure così intimo, un uomo forte e disperato, che alcuni chiamerebbero un eroe e altri un codardo. Sul suo volto vedo la pace. Mentre il personale dei servizi funebri lo porta via, mi sembra di sentire la sua voce che mi dice: «Sergio, non rompermi i coglioni».
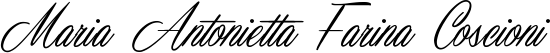




Devi accedere per postare un commento.