È cura solo se vi sono prove
L’accesso alle cure mediche, nei Paesi democratici, è regolato dalla legge. A tutela della salute dei cittadini. Ma anche della libertà di ricerca scientifica. C’è voluto oltre mezzo secolo del Novecento per capire in che modo si poteva interrompere, senza penalizzare l’avanzamento della medicina, la carneficina di bambini e adulti causata dall’assenza di regole nel passaggio dal laboratorio alla clinica. Legislatori e ricercatori non hanno avuto difficoltà a stabilire le regole, perché scienza e diritto parlano lo stesso linguaggio: quello delle prove.
Lascia dunque perplessi quanto sta accadendo intorno al dramma di una bambina, colpita da una grave malattia, e della sua famiglia. Il Tribunale di Venezia ha stabilito di far proseguire su questo paziente, presso gli Spedali Civili di Brescia, un trattamento con cellule cosiddette staminali, che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha giudicato prive dei requisiti di sicurezza ed efficacia per essere usate anche in via sperimentale. E per questo ne era stato sospeso l’uso clinico.
Anche se è difficile farsi ascoltare quando le emozioni prendono il sopravvento, bisogna
ribadire in che modo nascono le cure mediche. Cioè quali procedure garantiscono ai malati che, sottoponendosi a un trattamento approvato o in sperimentazione, non subiranno ulteriori danni, oltre la malattia. O non saranno imbrogliati. Ebbene si tratta di esaminare con obiettività delle prove.
La scienza ha sviluppato un articolato sistema per controllare le prove. Imperfetto: ma il migliore che esiste. Le indicazioni che una molecola chimica o delle cellule staminali possono curare una malattia vengono raccolte dai ricercatori, che le sottopongono al vaglio di colleghi, con la stessa o una superiore competenza. Solo dopo un esame severo dei dati può arrivare luce verde per la pubblicazione di quei risultati. Tralasciando gli aspetti commerciali, è solo a seguito del controllo pubblico delle prove che i medici, di ogni parte del mondo, potranno ripetere il trattamento e valutarne la solidità. Se è efficace, altri pazienti ne beneficeranno.
Se non funziona, l’ente e i ricercatori proponenti perderanno credibilità. Non è, però, la pubblicazione su “Science” o “Nature” a rendere una scoperta “vera”, ma il suo consolidamento nel tempo. Per “valere” il risultato deve essere pubblico e replicabile da altri. Il resto (che purtroppo esiste) non deve contare. Altrimenti le garanzie per le persone e la libertà di ricerca saltano per aria. Le scorciatoie servono ad andare sui giornali, avanzare in carriere farlocche o arricchirsi sfruttando la disperazione di malati e parenti. Non a trovare cure sicure ed efficaci. E solo una continua sorveglianza interna della comunità scientifica permette di sviluppare terapie affidabili, quanto più rapidamente possibile e neutralizzando i furbi.
Le sperimentazioni fatte su malati, sono “esperimenti” volti a cercare (in modo non casuale) le prove della sicurezza e dell’efficacia di una certa cura. Le prove a volte si trovano, altre no. Per prevenire tragedie e imbrogli, è obbligatorio il consenso informato del paziente e l’esame di comitati indipendenti. E andrebbero fatte senza annunciarne l’avvio per autocelebrarsi. Cioè senza generare aspettative, spesso infondate. Le aspettative sulle staminali sono smisurate rispetto alle conoscenze, e i continui annunci dannosi. Fanno credere che già curino e domani cureranno di più e tutto. Non è così. E per molte staminali e molte malattie, magari, non sarà mai così. Si contano sulle dita di una mano le malattie curate con staminali: leucemie e ustioni della pelle o della cornea. Il resto è ricerca che si muove verso frontiere inesplorate, senza garanzie di successo a priori. O è sperimentazione clinica. Che non è ancora terapia. Un trattamento non viene reso valido o giustificato dalla disponibilità a pagare, per attaccarsi a una speranza. Né da un qualsiasi imprimatur, religioso o etico-politico.
Nella vicenda bresciana si parla di “terapia compassionevole”. Non è così. L’espressione
indica l’impiego razionale di un trattamento, laddove non ve ne siano altri, in fase di sperimentazione clinica. Cioè di cui ancora non si sa se è sicuro ed efficace. E non deve
costare soldi al malato. Noi pensiamo che si possa anche ingannare il paziente, se non ci sono alternative e questi vuole essere ingannato. Se cioè gli fa bene. Ma basta una soluzione fisiologica e la simpatia (o come la chiamano oggi empatia) per questo. Altrimenti i motivi sono tutt’altro che benevoli.
Un giudice ha deciso che un malato deve continuare ad essere “trattato” con qualcosa che non si sa cosa sia, come funzioni e quali effetti produca. Alcuni familiari di malati con la stessa malattia chiedono perché un paziente sì, e altri no. Il giudice, in attesa di decidere in modo definitivo, dice che è rilevante per il caso specifico. Ma non è terapia, non è sperimentazione clinica, non è uso compassionevole. La medicina lavora nutrendosi anche di speranze. Ma, come il giudice che deve esprimere un verdetto, per essere “giusta” vuole le prove. Senza prove resta la speranza per una bambina con quel nome bellissimo. Nessuno può volerla distruggere. Ma non è medicina.
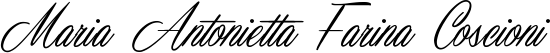



Devi accedere per postare un commento.